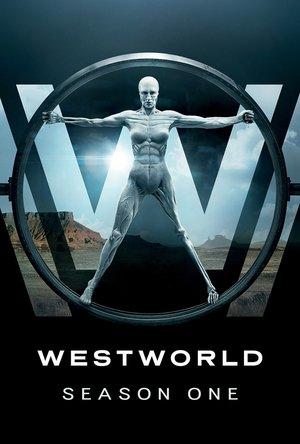Infinito alla deriva
È sempre difficile per me parlare delle cose che amo (anche se non so parlare di altro), perché ho sempre la sensazione di non rendere merito alla loro bellezza, perché significa parlare di me stesso, perché, più in generale, le cose belle sono incontenibili, straripano e non si possono arginare. Posso solo lasciarmi travolgere. Ed è ciò che faccio ogni giorno: lascio che la Bellezza mi faccia male come vuole. E cosi faccio quando scrivo: mi lascio cogliere dalla potenza delle parole e cerco di farmi il tramite della forza esplosiva che mi sceglie per manifestarsi. Quindi, parlare di Westworld, come di tutto ciò che amo, per me, vuol dire entrare in una cicatrice del mio cervello e danzare a ogni chiusi sull’orlo del precipizio del mio essere. Questa non è una recensione, dunque, è più che altro l’insieme delle sensazioni che questa serie tv ha suscitato in me, il mio personalissimo modo di vederla. Se proprio dovessi darne una definizione, direi che Westworld è un fiore vero in un campo di fiori di plastica, perché rappresenta un prodotto estetico di altissimo livello; è semplicemente una delle migliori serie televisive che abbia mai avuto il piacere di vedere.
[...e di serie tv meravigliose, per fortuna, ce ne sono tante. ne cito a casa qualcuna: Fargo (in particolare la seconda e la terza stagione: immense), True Detective (sì, anche la seconda stagione, criticata da tutti), Breaking Bad (ogni singolo fotogramma è magia), e tantissime altre, fino alla più bella di tutte, la più importante, più trascendente, incredibile, stupefacente, immortale, che è Twin Peaks (e la terza stagione è semplicemente uno dei momenti più alti della storia della nostra specie)].
La bellezza della complessità di Westworld è molto vicina a quella poesia di cui il mondo ha bisogno. È affascinante e al contempo, o per questo, destabilizzante, come la carezza di uno sconosciuto. È vortice e cornice, perché scava e riflette, come un oceano affamato.
Westworld ti rassicura, perché parla con te.
Westworld ti spaventa, perché parla di te.
La complessità della sua bellezza è molto vicina a quel mondo di cui la poesia ha bisogno. È perturbante in senso freudiano. Perché non è fine a sé stessa, perché è costantemente tesa verso quell’infinito di cui canta Baudelaire, verso quel meraviglioso che Aristotele ha indicato essere la dimensione abitativa dell’arte. L’universo creato da Jonathan Nolan e Lisa Joy è fortemente articolato, dettagliato secondo il criterio più "naturale": il caso. I pianeti che abitano questo universo siamo noi, e siamo anche i satelliti che vi orbitano intorno, gli esseri che vivono, che muoiono e che nascono continuamente. Perciò ho amato questa serie. Per il peso delle palpebre che non contiene il fluire degli sguardi, per la complessità dei personaggi che ti entrano dentro a fecondare il cervello di nuove esistenze, per la morte con cui dipinge la vita, per la dimensione metonimica degli eventi, per la vita con cui colora la morte. Per questo continuo ad amarla.
[A ogni modo, non intendo parlare di Westworld in sé, ma di Westworld in me (come faccio ogni volta, del resto). Voglio provare a parlare del modo in cui continuo a varcare certe soglie di me stesso. Farò riferimento soprattutto alla prima stagione, benché abbia visto e apprezzato tutte le tre stagioni finora realizzate, perché nella prima si dispiega uno scenario di senso che riesce a raggiungere vette estetiche enormi, e soprattutto si mette in scena una narrazione che si avvicina moltissimo al mio modo di intendere e studiare la comunicazione.]
Prima ho utilizzato il termine poesia – una parola usata quasi sempre a sproposito e che esprime e sottende uno dei concetti più violentati di sempre – ma in riferimento a Westworld non è fuori luogo. La portata narrativa della serie, il complesso dei rimandi di cui è costituita, la straordinaria mole di connessioni tra le variabili che ne strutturano la sostanza, e più in generale la forza mitopoietica della sua messa in scena, sono elementi che, in misura più o meno variabile, costituiscono il terreno fertile del dire poetico. Voglio dire, la poesia è la sola forma del sentire umano che non conosce contenuto: non è un insieme di versi, non è scrittura, o meglio non solo questo, ma è tutto ciò che è altro da sé, che è possibilità e non certezza, che è assenza e non presenza, che è fantasma e non vita né morte. Perciò qualsiasi espressione della nostra specie può ambire al rango di poesia, qualunque prodotto estetico può rientrare nella definizione di poesia, e Westworld vi rientra in pieno. Ogni aspetto, ogni dettaglio, è portatore di significato, ogni fotogramma è insostituibile: non si possono apportare variazioni senza sconvolgere il senso generale dell’opera. La forza dei dialoghi, delle singole parole, è davvero notevole. Tagliano dentro, come direbbe l’Uomo in nero. La ripetizione delle scene è il punto di forza: è un eterno ritorno, un’onda che continua a frangersi su una riva che si sorprende ogni volta.
Westworld si presenta come un estraneo che sa tutto di te. È inverno e piove oppure è una torrida estate, uno sconosciuto ti ferma per strada e inizia a parlare di te, delle tue profondità, tu hai lo sguardo basso perché camminavi pensieroso, ti terrorizza quello che senti, ma allo stesso tempo provi una sensazione di calore domestico, sei al sicuro in mezzo a una tempesta di proiettili, forse perché sei già morto, e quando ti decidi ad alzare lo sguardo e a guardare negli occhi lo sconosciuto, vedi solo la folla del marciapiede. Benvenuto a Westworld.
I dieci episodi della prima stagione, come faranno poi anche quelli delle stagioni successive, si mescolano di continuo. Si intrecciano e si mischiano, irradiando percorsi identitari che ognuno di noi è portato a percorrere. Traiettorie di senso che ciascuno di noi, in maniera più o meno consapevole, decide di indossare al fine di definire la propria biografia esistenziale.
Che altro è, Westworld, se non questo?
Un tentativo di affermazione della propria identità. Un tentativo inevitabile, indomito, vano, necessario, vitale, distruttivo, in costante divenire. Westworld è una passeggiata sulle scale di Escher.
Ci parla del più antico sentimento umano, di quella primordiale essenza, della prima parola pronunciata dall’uomo.
«Io esisto».
Nient’altro.
Dalle caverne a facebook, l’individuo non fa altro che ripetere questo; ogni sua azione, ogni sua parola, qualsiasi sua espressione, non sono altro che modi diversi di affermare se stessi, di continuare a dire «io esisto», «questo sono io».
La serie di Nolan ci parla esattamente di questo, del labile e precario equilibrio di un fiore che sboccia dentro un temporale.
A mio modo di vedere (sentire, toccare, gustare, annusare), un possibile modo di affrontare le sterminate considerazioni su Westworld, è quello di articolare il discorso intorno ad alcuni termini chiave, attraverso i quali sviluppare le proprie riflessioni. Ecco le mie considerazioni.
Identità
Quello dell’identità è il tema intorno al quale ruota l’intera serie. Chi sono io? È la domanda più antica, il demone più feroce. L’aspetto che mi ha fatto impazzire di Westworld è la declinazione di identità che ci viene offerta: identità è narrazione. La sociologia (la mia sociologia, almeno) ce lo dice da sempre, la poesia da molto prima: noi siamo storie, siamo racconti, siamo le parole che racchiudono i nostri ricordi, che li modificano e, soprattutto, li offrono agli altri. In altri termini, siamo costruzioni. Westworld coglie nel segno. Siamo narrazioni. A tutti i livelli. Androidi e esseri umani, ognuno è una storia. Storie che hanno senso solo se c’è qualcuno che ascolta (da qui l’incessante e vitale bisogno umano di comunicare se stesso). Chi sono io? Bernard se lo chiede più volte, per ogni maschera del suo personaggio, per dirla alla Pirandello. Chi sono io? È una domanda che ricorre spesso nel corso degli eventi della nostra vita. La risposta non si trova dentro di noi, ma negli altri. La verità è la fuori, per citare X-Files. E questo Westworld lo dice chiaramente: noi siamo storie, noi siamo costruzioni, la nostra identità è un mosaico costituito da infinite tessere. Allora è per questo che la coscienza non può avere altra forma che quella del labirinto: trovare se stessi equivale a conoscere gli altri, a farsi penetrare dall’esistenza, dalla somma di emozioni che giace nel profondo di ogni individuo, vivo o morto, reale o immaginario, ed è ciò che fa Dolores. Non esiste altra via per arrivare a sé, del resto ogni labirinto ha una sola strada giusta, tutte le altre sono trame che collassano su se stesse, e malgrado ciò, o forse proprio grazie a ciò, sono portatrici di significato, sono indispensabili. Westworld stesso è un labirinto, tutte le opere d’arte lo sono: meccanismi che ti inglobano nella tua totalità, che ti fanno male, per poi restituirti mutato, fiorito, sanguinante, vivo.
Natura
Il concetto di identità è inestricabilmente legato a quello di natura. Ognuno è ciò che è, certo, ma ognuno è anche ciò che non è. Westworld è un viaggio nella natura umana – qualsiasi cosa essa sia. È un ricamo di sentimenti primordiali e paure future, una tessitura di dettagli inventati per essere veri. Ford e Arnold, nel loro lavoro, non fanno che affondare le mani (letteralmente e metaforicamente) nel cuore degli androidi, chiedendosi se siano più veri i battiti di questi ultimi o quelli del loro cuore. Westworld è una foto di un bosco affollato di animali affamati. Ci parla dell’individuo e del mondo che abita, delle qualità dell’uno e dell’altro. I cicli narrativi sono il giorno che segue la notte a cui seguirà un nuovo giorno. È la ripetizione la natura delle cose. Come l’onda che si frange sulla riva, come le stagioni, come le maree, come le stelle che muoiono, come i fiori che sbocciano. Westworld ci parla di vita e di morte, ma in realtà non parla di nessuna delle due: Westworld è il racconto della nascita, del venire al mondo. È la natività della coscienza. Nella mangiatoia primordiale della mente umana, quella precedente alla comparsa dei sapiens, qualcosa si accorge di esistere: Westworld ci parla di questo, di un evento di milioni di anni fa, che si ripete ogni istante. Ed è paradigmatico il fatto che questa serie si basi interamente sul concetto di natura, nel senso più ampio e nelle molte accezioni del termine: perché la natura, in natura, non esiste. Fino all’avvento delle macchine e dei processi di industrializzazione non esiste la natura, non poteva esistere, è stata una “scoperta” della modernità. Così come non può esistere il bene senza il male, l’acceso senza lo spento, il bello senza il brutto, così non può esistere natura senza una sua controparte, che identificherei con il termine di "cultura" (anche se in realtà non si tratta di elementi opposti, ma conmplementari). Ecco la natura di cui ci parlano i personaggi di Westworld: una natura, quella umana, che trova la sua controparte, quella degli androidi, e che solo in questo modo può iniziare a esistere. È la nascita della natura umana, e come ogni nascita avviene tra urla, dolore, sangue e squarci di luce.
Realtà
La realtà del mondo di Westworld è finzione scenica, ovvero la realtà più autentica che l’essere umano possa mai conoscere. Il mondo è un palcoscenico e noi siamo attori, diceva Shakespeare; ce lo ricorda anche Goffman quando ci dice che gli individui intendono «la vita quotidiana come rappresentazione». Westworld è la messa in scena di una messa in scena che mette in scena una messa in scena. Meave si chiede continuamente quale sia la realtà, quale sia invece il sogno (ammesso che siano antitetici e non versioni di una stessa cosa); arriva un momento in cui crede di avere la risposta, lo crediamo anche noi, forse ci speriamo: perché ognuno di noi è Meave, e abbiamo bisogno di credere che la risposta esista, che sia a portata di mano. Dobbiamo credere di essere reali, di avere senso, che il nostro respiro fecondi l’aria. La realtà, come l’arte, è ciò che diciamo sia tale. Esiste tutto ciò che crediamo esista. Perfino tu, anonimo lettore, perfino tu potresti essere reale. Ciao, Meave. Cosa c’è nella tua borsa? La (mia) realtà è così: un gomitolo impazzito. E come Bernard mi chiedo quale sia il significato di essere vivo. Forse morti si nasce, vivi si diventa. Non lo so. Bernard, in questo senso, è più vivo di Sizemore (personaggio che, nella seconda stagione, conoscerà una trasformazione decisamente significativa: in qualche modo, “nascerà” anche lui). Ogni realtà, tuttavia, in quanto tale, contiene in sé il seme della sua estinzione: perché il reale è un atto estremo e profondo di immaginazione. Lo capisce Meave, quando parla con Felix e Sylvester; lo capisce Bernard, quando varca con Theresa la soglia della porta invisibile ai suoi occhi. Westworld, in breve, ci ricorda che tutto ciò che noi facciamo rientrare nel concetto di realtà è una complessa costruzione che poggia su un equilibrio instabile e pericolante; allora è comprensibile (è “umano”) porsi delle domande, dubitare di tutto, anche di sé stessi (come Felix). Westworld ha scatenato molto discussioni, una caccia al dettaglio, in rete si può leggere di tutto, ogni tipo di teoria e di spiegazione, perché il dubbio che Westworld semina germoglia in fretta, e ci si chiede fino a che punto si può credere a quanto visto, se in realtà non ci sia altro, qualcosa di nascosto, ma la risposta a mio avviso è semplice: non c’è niente di più di quello che c’è, la serie non bara, that’s all, folks. A prescindere da ogni cosa, comunque, la realtà di cui ci parla Westworld rispecchia alla perfezione il pensiero di William Thomas: se gli individui definiscono certe situazioni come reali, esse saranno reali nelle loro conseguenze.
Specchio
Uno degli strumenti principali che contribuisce a costruire, e periodicamente a rifondare, il concetto di realtà, e per estensione di identità, è senza dubbio lo specchio. Sulla sua superficie si riflette l’immagine del nostro corpo, e in quel riflesso abbiamo la percezione unitario del nostro essere, ci ri-conosciamo. L’occhio è l’organo umano che permette all’individuo di vedere, ma lo sguardo non esiste in natura: è un “dispositivo” culturale, un’invenzione della nostra specie che ci ha permesse di fare arte. Westworld ci parla di questa differenza, quella che sta tra occhi e sguardo. Westworld è uno specchio, e sulla sua superficie vediamo riflessi i nostri corpi che amano, piangono, sanguinano, ridono, muoiono, sognano. Quando Bernard guarda i disegni di Ford, quelli che riguardano la sua nascita/costruzione, lì, in quel frangente, io vedo una splendida metafora di quella stadio dello specchio di cui ha parlato Lacan. Bernard si specchia sulla carta. Noi ci specchiamo in lui. Un gioco di riflessi che parte da e conduce all’individuo nella sua complessità. Lo stadio dello specchio è la presa di coscienza, del Sé e del mondo circostante, da parte dell’infante; ma è anche la presa di coscienza del nostro antenato più lontano che, vedendosi riflesso su uno specchio d’acqua, disse “quello lì che mi guarda sono io”. E allora Westworld funge da fiume, da superficie riflettente, tanto per gli androidi che vi abitano (es. Dolores), tanto per gli esseri umani che vi fanno visita (es. Logan) o che lì lavorano (es. Felix): è un occhio che impara a guardare. Voglio continuare a parlare dello specchio come strumento di costruzione della propria identità attraverso un paragone che mi affascina molto. Dolores è Alice che attraversa lo specchio. Il suo viaggio, l’alba della sua coscienza, è un raggio di luce che si frange sul mondo dando vita ai colori. Come il personaggio raccontato da Carrol, Dolores affonda lo sguardo tendendolo verso l’oltre, si muove dietro il già visto, portandosi dietro la cornice del così è, in altre parole crea connessioni e tesse percorsi identitari su una soglia di rifondazione dell’esperienza e del significato che la portano a immergersi totalmente nelle traiettorie disegnate da Arnold e Ford, ovvero a raggiungere la cima della piramide, e come Alice che alla fine si sveglia, così Dolores si accorge, e noi con lei, che la piramide e in realtà un cerchio, e che il punto di arrivo è il punto di partenza: se stessa, ma stavolta consapevole di essere, di esserci, perché, guardandosi allo specchio, ha imparato a riconoscersi.
Metafora
Questo è l’aspetto che fa di Westworld un’opera d’arte: è altro da sé, ovvero è metafora. Attraverso il racconto di un mondo fantascientifico, di personaggi sottilmente complessi ed estrema cura del dettaglio, questa serie ci parla della natura umana – dei suoi primordi, del suo adattamento, della sua distruttiva creatività – narrando le vicende che portano allo sbocciare della coscienza nei robot che abitano il parco. Tutto è altro. Ognuno è qualcun altro. E ciascuno può essere se stesso solo attraverso gli altri. L’individuo è uno e molteplice. Così come non può esserci natura senza una sua controparte, così non può esserci l’Io senza un Altro in cui specchiarsi, a cui raccontare la propria identità. Perché siamo fiumi che scorrono senza senso lungo letti privi di argini, completamente insignificanti, fiumi che possono ambire a diventare oceano solo se imparano a nutrirsi di affluenti. Senza, saremmo solo un infinito alla deriva.
[...e di serie tv meravigliose, per fortuna, ce ne sono tante. ne cito a casa qualcuna: Fargo (in particolare la seconda e la terza stagione: immense), True Detective (sì, anche la seconda stagione, criticata da tutti), Breaking Bad (ogni singolo fotogramma è magia), e tantissime altre, fino alla più bella di tutte, la più importante, più trascendente, incredibile, stupefacente, immortale, che è Twin Peaks (e la terza stagione è semplicemente uno dei momenti più alti della storia della nostra specie)].
La bellezza della complessità di Westworld è molto vicina a quella poesia di cui il mondo ha bisogno. È affascinante e al contempo, o per questo, destabilizzante, come la carezza di uno sconosciuto. È vortice e cornice, perché scava e riflette, come un oceano affamato.
Westworld ti rassicura, perché parla con te.
Westworld ti spaventa, perché parla di te.
La complessità della sua bellezza è molto vicina a quel mondo di cui la poesia ha bisogno. È perturbante in senso freudiano. Perché non è fine a sé stessa, perché è costantemente tesa verso quell’infinito di cui canta Baudelaire, verso quel meraviglioso che Aristotele ha indicato essere la dimensione abitativa dell’arte. L’universo creato da Jonathan Nolan e Lisa Joy è fortemente articolato, dettagliato secondo il criterio più "naturale": il caso. I pianeti che abitano questo universo siamo noi, e siamo anche i satelliti che vi orbitano intorno, gli esseri che vivono, che muoiono e che nascono continuamente. Perciò ho amato questa serie. Per il peso delle palpebre che non contiene il fluire degli sguardi, per la complessità dei personaggi che ti entrano dentro a fecondare il cervello di nuove esistenze, per la morte con cui dipinge la vita, per la dimensione metonimica degli eventi, per la vita con cui colora la morte. Per questo continuo ad amarla.
[A ogni modo, non intendo parlare di Westworld in sé, ma di Westworld in me (come faccio ogni volta, del resto). Voglio provare a parlare del modo in cui continuo a varcare certe soglie di me stesso. Farò riferimento soprattutto alla prima stagione, benché abbia visto e apprezzato tutte le tre stagioni finora realizzate, perché nella prima si dispiega uno scenario di senso che riesce a raggiungere vette estetiche enormi, e soprattutto si mette in scena una narrazione che si avvicina moltissimo al mio modo di intendere e studiare la comunicazione.]
Prima ho utilizzato il termine poesia – una parola usata quasi sempre a sproposito e che esprime e sottende uno dei concetti più violentati di sempre – ma in riferimento a Westworld non è fuori luogo. La portata narrativa della serie, il complesso dei rimandi di cui è costituita, la straordinaria mole di connessioni tra le variabili che ne strutturano la sostanza, e più in generale la forza mitopoietica della sua messa in scena, sono elementi che, in misura più o meno variabile, costituiscono il terreno fertile del dire poetico. Voglio dire, la poesia è la sola forma del sentire umano che non conosce contenuto: non è un insieme di versi, non è scrittura, o meglio non solo questo, ma è tutto ciò che è altro da sé, che è possibilità e non certezza, che è assenza e non presenza, che è fantasma e non vita né morte. Perciò qualsiasi espressione della nostra specie può ambire al rango di poesia, qualunque prodotto estetico può rientrare nella definizione di poesia, e Westworld vi rientra in pieno. Ogni aspetto, ogni dettaglio, è portatore di significato, ogni fotogramma è insostituibile: non si possono apportare variazioni senza sconvolgere il senso generale dell’opera. La forza dei dialoghi, delle singole parole, è davvero notevole. Tagliano dentro, come direbbe l’Uomo in nero. La ripetizione delle scene è il punto di forza: è un eterno ritorno, un’onda che continua a frangersi su una riva che si sorprende ogni volta.
Westworld si presenta come un estraneo che sa tutto di te. È inverno e piove oppure è una torrida estate, uno sconosciuto ti ferma per strada e inizia a parlare di te, delle tue profondità, tu hai lo sguardo basso perché camminavi pensieroso, ti terrorizza quello che senti, ma allo stesso tempo provi una sensazione di calore domestico, sei al sicuro in mezzo a una tempesta di proiettili, forse perché sei già morto, e quando ti decidi ad alzare lo sguardo e a guardare negli occhi lo sconosciuto, vedi solo la folla del marciapiede. Benvenuto a Westworld.
I dieci episodi della prima stagione, come faranno poi anche quelli delle stagioni successive, si mescolano di continuo. Si intrecciano e si mischiano, irradiando percorsi identitari che ognuno di noi è portato a percorrere. Traiettorie di senso che ciascuno di noi, in maniera più o meno consapevole, decide di indossare al fine di definire la propria biografia esistenziale.
Che altro è, Westworld, se non questo?
Un tentativo di affermazione della propria identità. Un tentativo inevitabile, indomito, vano, necessario, vitale, distruttivo, in costante divenire. Westworld è una passeggiata sulle scale di Escher.
Ci parla del più antico sentimento umano, di quella primordiale essenza, della prima parola pronunciata dall’uomo.
«Io esisto».
Nient’altro.
Dalle caverne a facebook, l’individuo non fa altro che ripetere questo; ogni sua azione, ogni sua parola, qualsiasi sua espressione, non sono altro che modi diversi di affermare se stessi, di continuare a dire «io esisto», «questo sono io».
La serie di Nolan ci parla esattamente di questo, del labile e precario equilibrio di un fiore che sboccia dentro un temporale.
A mio modo di vedere (sentire, toccare, gustare, annusare), un possibile modo di affrontare le sterminate considerazioni su Westworld, è quello di articolare il discorso intorno ad alcuni termini chiave, attraverso i quali sviluppare le proprie riflessioni. Ecco le mie considerazioni.
Identità
Quello dell’identità è il tema intorno al quale ruota l’intera serie. Chi sono io? È la domanda più antica, il demone più feroce. L’aspetto che mi ha fatto impazzire di Westworld è la declinazione di identità che ci viene offerta: identità è narrazione. La sociologia (la mia sociologia, almeno) ce lo dice da sempre, la poesia da molto prima: noi siamo storie, siamo racconti, siamo le parole che racchiudono i nostri ricordi, che li modificano e, soprattutto, li offrono agli altri. In altri termini, siamo costruzioni. Westworld coglie nel segno. Siamo narrazioni. A tutti i livelli. Androidi e esseri umani, ognuno è una storia. Storie che hanno senso solo se c’è qualcuno che ascolta (da qui l’incessante e vitale bisogno umano di comunicare se stesso). Chi sono io? Bernard se lo chiede più volte, per ogni maschera del suo personaggio, per dirla alla Pirandello. Chi sono io? È una domanda che ricorre spesso nel corso degli eventi della nostra vita. La risposta non si trova dentro di noi, ma negli altri. La verità è la fuori, per citare X-Files. E questo Westworld lo dice chiaramente: noi siamo storie, noi siamo costruzioni, la nostra identità è un mosaico costituito da infinite tessere. Allora è per questo che la coscienza non può avere altra forma che quella del labirinto: trovare se stessi equivale a conoscere gli altri, a farsi penetrare dall’esistenza, dalla somma di emozioni che giace nel profondo di ogni individuo, vivo o morto, reale o immaginario, ed è ciò che fa Dolores. Non esiste altra via per arrivare a sé, del resto ogni labirinto ha una sola strada giusta, tutte le altre sono trame che collassano su se stesse, e malgrado ciò, o forse proprio grazie a ciò, sono portatrici di significato, sono indispensabili. Westworld stesso è un labirinto, tutte le opere d’arte lo sono: meccanismi che ti inglobano nella tua totalità, che ti fanno male, per poi restituirti mutato, fiorito, sanguinante, vivo.
Natura
Il concetto di identità è inestricabilmente legato a quello di natura. Ognuno è ciò che è, certo, ma ognuno è anche ciò che non è. Westworld è un viaggio nella natura umana – qualsiasi cosa essa sia. È un ricamo di sentimenti primordiali e paure future, una tessitura di dettagli inventati per essere veri. Ford e Arnold, nel loro lavoro, non fanno che affondare le mani (letteralmente e metaforicamente) nel cuore degli androidi, chiedendosi se siano più veri i battiti di questi ultimi o quelli del loro cuore. Westworld è una foto di un bosco affollato di animali affamati. Ci parla dell’individuo e del mondo che abita, delle qualità dell’uno e dell’altro. I cicli narrativi sono il giorno che segue la notte a cui seguirà un nuovo giorno. È la ripetizione la natura delle cose. Come l’onda che si frange sulla riva, come le stagioni, come le maree, come le stelle che muoiono, come i fiori che sbocciano. Westworld ci parla di vita e di morte, ma in realtà non parla di nessuna delle due: Westworld è il racconto della nascita, del venire al mondo. È la natività della coscienza. Nella mangiatoia primordiale della mente umana, quella precedente alla comparsa dei sapiens, qualcosa si accorge di esistere: Westworld ci parla di questo, di un evento di milioni di anni fa, che si ripete ogni istante. Ed è paradigmatico il fatto che questa serie si basi interamente sul concetto di natura, nel senso più ampio e nelle molte accezioni del termine: perché la natura, in natura, non esiste. Fino all’avvento delle macchine e dei processi di industrializzazione non esiste la natura, non poteva esistere, è stata una “scoperta” della modernità. Così come non può esistere il bene senza il male, l’acceso senza lo spento, il bello senza il brutto, così non può esistere natura senza una sua controparte, che identificherei con il termine di "cultura" (anche se in realtà non si tratta di elementi opposti, ma conmplementari). Ecco la natura di cui ci parlano i personaggi di Westworld: una natura, quella umana, che trova la sua controparte, quella degli androidi, e che solo in questo modo può iniziare a esistere. È la nascita della natura umana, e come ogni nascita avviene tra urla, dolore, sangue e squarci di luce.
Realtà
La realtà del mondo di Westworld è finzione scenica, ovvero la realtà più autentica che l’essere umano possa mai conoscere. Il mondo è un palcoscenico e noi siamo attori, diceva Shakespeare; ce lo ricorda anche Goffman quando ci dice che gli individui intendono «la vita quotidiana come rappresentazione». Westworld è la messa in scena di una messa in scena che mette in scena una messa in scena. Meave si chiede continuamente quale sia la realtà, quale sia invece il sogno (ammesso che siano antitetici e non versioni di una stessa cosa); arriva un momento in cui crede di avere la risposta, lo crediamo anche noi, forse ci speriamo: perché ognuno di noi è Meave, e abbiamo bisogno di credere che la risposta esista, che sia a portata di mano. Dobbiamo credere di essere reali, di avere senso, che il nostro respiro fecondi l’aria. La realtà, come l’arte, è ciò che diciamo sia tale. Esiste tutto ciò che crediamo esista. Perfino tu, anonimo lettore, perfino tu potresti essere reale. Ciao, Meave. Cosa c’è nella tua borsa? La (mia) realtà è così: un gomitolo impazzito. E come Bernard mi chiedo quale sia il significato di essere vivo. Forse morti si nasce, vivi si diventa. Non lo so. Bernard, in questo senso, è più vivo di Sizemore (personaggio che, nella seconda stagione, conoscerà una trasformazione decisamente significativa: in qualche modo, “nascerà” anche lui). Ogni realtà, tuttavia, in quanto tale, contiene in sé il seme della sua estinzione: perché il reale è un atto estremo e profondo di immaginazione. Lo capisce Meave, quando parla con Felix e Sylvester; lo capisce Bernard, quando varca con Theresa la soglia della porta invisibile ai suoi occhi. Westworld, in breve, ci ricorda che tutto ciò che noi facciamo rientrare nel concetto di realtà è una complessa costruzione che poggia su un equilibrio instabile e pericolante; allora è comprensibile (è “umano”) porsi delle domande, dubitare di tutto, anche di sé stessi (come Felix). Westworld ha scatenato molto discussioni, una caccia al dettaglio, in rete si può leggere di tutto, ogni tipo di teoria e di spiegazione, perché il dubbio che Westworld semina germoglia in fretta, e ci si chiede fino a che punto si può credere a quanto visto, se in realtà non ci sia altro, qualcosa di nascosto, ma la risposta a mio avviso è semplice: non c’è niente di più di quello che c’è, la serie non bara, that’s all, folks. A prescindere da ogni cosa, comunque, la realtà di cui ci parla Westworld rispecchia alla perfezione il pensiero di William Thomas: se gli individui definiscono certe situazioni come reali, esse saranno reali nelle loro conseguenze.
Specchio
Uno degli strumenti principali che contribuisce a costruire, e periodicamente a rifondare, il concetto di realtà, e per estensione di identità, è senza dubbio lo specchio. Sulla sua superficie si riflette l’immagine del nostro corpo, e in quel riflesso abbiamo la percezione unitario del nostro essere, ci ri-conosciamo. L’occhio è l’organo umano che permette all’individuo di vedere, ma lo sguardo non esiste in natura: è un “dispositivo” culturale, un’invenzione della nostra specie che ci ha permesse di fare arte. Westworld ci parla di questa differenza, quella che sta tra occhi e sguardo. Westworld è uno specchio, e sulla sua superficie vediamo riflessi i nostri corpi che amano, piangono, sanguinano, ridono, muoiono, sognano. Quando Bernard guarda i disegni di Ford, quelli che riguardano la sua nascita/costruzione, lì, in quel frangente, io vedo una splendida metafora di quella stadio dello specchio di cui ha parlato Lacan. Bernard si specchia sulla carta. Noi ci specchiamo in lui. Un gioco di riflessi che parte da e conduce all’individuo nella sua complessità. Lo stadio dello specchio è la presa di coscienza, del Sé e del mondo circostante, da parte dell’infante; ma è anche la presa di coscienza del nostro antenato più lontano che, vedendosi riflesso su uno specchio d’acqua, disse “quello lì che mi guarda sono io”. E allora Westworld funge da fiume, da superficie riflettente, tanto per gli androidi che vi abitano (es. Dolores), tanto per gli esseri umani che vi fanno visita (es. Logan) o che lì lavorano (es. Felix): è un occhio che impara a guardare. Voglio continuare a parlare dello specchio come strumento di costruzione della propria identità attraverso un paragone che mi affascina molto. Dolores è Alice che attraversa lo specchio. Il suo viaggio, l’alba della sua coscienza, è un raggio di luce che si frange sul mondo dando vita ai colori. Come il personaggio raccontato da Carrol, Dolores affonda lo sguardo tendendolo verso l’oltre, si muove dietro il già visto, portandosi dietro la cornice del così è, in altre parole crea connessioni e tesse percorsi identitari su una soglia di rifondazione dell’esperienza e del significato che la portano a immergersi totalmente nelle traiettorie disegnate da Arnold e Ford, ovvero a raggiungere la cima della piramide, e come Alice che alla fine si sveglia, così Dolores si accorge, e noi con lei, che la piramide e in realtà un cerchio, e che il punto di arrivo è il punto di partenza: se stessa, ma stavolta consapevole di essere, di esserci, perché, guardandosi allo specchio, ha imparato a riconoscersi.
Metafora
Questo è l’aspetto che fa di Westworld un’opera d’arte: è altro da sé, ovvero è metafora. Attraverso il racconto di un mondo fantascientifico, di personaggi sottilmente complessi ed estrema cura del dettaglio, questa serie ci parla della natura umana – dei suoi primordi, del suo adattamento, della sua distruttiva creatività – narrando le vicende che portano allo sbocciare della coscienza nei robot che abitano il parco. Tutto è altro. Ognuno è qualcun altro. E ciascuno può essere se stesso solo attraverso gli altri. L’individuo è uno e molteplice. Così come non può esserci natura senza una sua controparte, così non può esserci l’Io senza un Altro in cui specchiarsi, a cui raccontare la propria identità. Perché siamo fiumi che scorrono senza senso lungo letti privi di argini, completamente insignificanti, fiumi che possono ambire a diventare oceano solo se imparano a nutrirsi di affluenti. Senza, saremmo solo un infinito alla deriva.