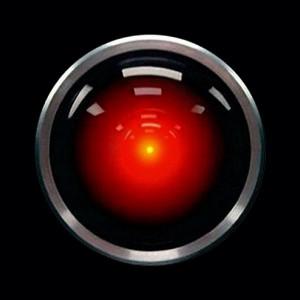Ultima trasposizione cinematografica del celebre romanzo sci-fi scritto da Frank Herbert, Il Dune di Villeneuve racchiude in sé almeno tre linee narrative che possono essere ricondotte a dimensioni differenti. In primis l’aspetto geopolitico, largamente sovrapponibile alla storia di tanti paesi europei colonizzatori che assoggettano altri popoli per sfruttare le preziose materie prime custodite nella loro terra (la spezia su Arrakis, il coltan in Congo). C’è poi una seconda componente, più intima, che segue l’evoluzione del protagonista, Paul Atreides, Figlio del Duca Leto e in quanto tale destinato a prenderne il posto. In realtà, il giovane Paul si dimostra combattuto: l’eredità che lo attende è davvero la strada giusta per il futuro? “Se la tua risposta è no sarai comunque quello che volevo che tu fossi: mio figlio”, afferma laconico il padre. La madre, invece, ha le idee molto più chiare e cerca di convincerlo attraverso i suoi insegnamenti. Tuttavia, quando Paul comprende che per lui c’è un disegno ben preciso, si sente inerme, prigioniero, una biglia in un percorso già segnato. Comincia così a interrogarsi sul libero arbitrio, in particolare sull’impossibilità di essere veramente liberi. D’altro canto, tale condizione lo accomuna ai Fremen, popolo custode del deserto di Arrakis che vede in lui la figura messianica attesa da tempo. Ma egli non si lascia lusingare, poiché, come accade in qualsiasi forma di religione, costoro “vedono ciò che gli è stato detto di vedere”. Insomma, Paul è alla ricerca di sé, di un posto nel mondo, di un’identità sempre più lontana e sfuggente. Per sua fortuna, presto scoprirà che non serve cercare di capire tutto del mondo, ma che il mondo bisogna viverlo lasciandosi attraversare da esso. Solo così è possibile trasformare la casualità in destino, il proprio. Peraltro, traspare in questa filosofia un’idea precisa del rapporto con l’ambiente che designa il terzo piano narrativo, riconducibile alle tradizioni del popolo Fremen. Anch’essi usano la spezia, ma, come le antiche civiltà sudamericane, lo fanno per i suoi poteri magici e allucinogeni, con venerazione e forte senso di spiritualità, onorando il legame atavico tra essere umano e natura. Per converso, le altre casate rappresentano i Bolsonaro, i Trump, ossia l’ideologia occidentale dell’uomo moderno che plasma il pianeta a sua immagine e necessità imponendosi come specie dominante.
Evidentemente, questo Dune offre molti piani di lettura, seppure nell’ambito di un intreccio abbastanza noto e in parte già visto, ma dove tutto si dipana in modo chiaro, facendo sì che persino i temuti “spiegoni” giungano al momento giusto, senza risultare molesti. Certo, nella straordinaria filmografia del regista la pellicola rischia seriamente di guadagnare l’ultimo posto, ma in fondo stiamo parlando di Villeneuve, un artista di livello talmente superiore che anche quando si mette gli infradito, girando (forse) il più debole dei suoi film, ci regala comunque una grande opera, come sempre ineccepibile dal punto di vista tecnico, anche se meno visionaria di quanto mi aspettassi. A tal proposito, ritengo la rappresentazione lynchana del Barone di Harkonnen molto più convincente, mentre la versione di Villeneuve risulta troppo pacata nella sua brutalità, troppo silenziosa e meditabonda. Nel film di Lynch il villain ostentava rumorosamente e con spietata goliardia la propria malvagità, rendendolo a mio giudizio ancora più cattivo e temibile. Di contro, lo Stellan Skarsgård avvolto nel trucco prostatico che si aggira indolente tra le inquadrature ricorda, più che altro, uno zio ingordo in preda alla tipica sonnolenza postprandiale. Ancora peggio, però, Zendaya, che non sembra aver imparato nuove espressioni facciali oltre alla solita smorfia in cui si condensano, contemporaneamente, gli stessi tre sentimenti, meglio noti come le tre “s” di Zendaya: sfida, schifo, superiorità.
In conclusione, è bene ricordare come ogni giudizio definitivo non possa che essere rimandato, poiché la pellicola costituisce solo la prima parte di quella che dovrà essere, auspicabilmente, una trilogia. Per ora, la voglia di tornare al cinema c’è. E va benissimo così.