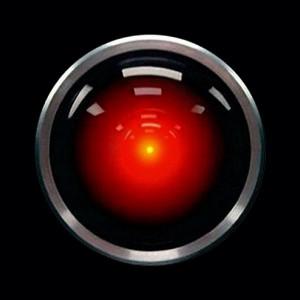Il coma di un guerriero costringe la moglie ad accudirlo, ma innesca nella donna un flusso di coscienza che la porterà a mettere in dubbio la forza e il senso della loro relazione, irrimediabilmente intrappolata nei precetti dell’Islam.
Sullo sfondo di un territorio afghano oppresso dalla guerriglia, in cui la vita quotidiana ha dovuto farsi spazio tra violenze, razzie, sparatorie e bombardamenti, una giovane donna si trova sola a prendersi cura del marito, ex combattente gravemente ferito e ridotto in stato vegetativo. Mentre gli usa le sue premure, il corpo del coniuge, fisicamente e simbolicamente pietrificato, assume forza vitale, inducendola a confessare segreti insostenibili e a sprigionare sentimenti repressi. Libera della gabbia coranica, la donna riversa prepotentemente il suo dolore sull’uomo inerme, che per la prima volta sarà costretto a prestarle ascolto.
Come pietra paziente non parla solo dalla sofferenza di tutte le ragazze musulmane, alle quali viene negato il diritto ad una vita di coppia serena e genuina. Se l’amore in quanto sentimento universale nutre l’empatia umana che spinge ad unirci, i diversi codici culturali, in questo caso le prescrizioni della fede, agiscono con logica esclusiva; imponendo le differenze, educano alla distanza e pertanto ottundono la compassione. I cittadini del mondo occidentale secolarizzato, in preda alla sbornia da libertà dei costumi, potrebbero guardare il film con rassicurante distacco, ma sarebbe illusorio. In effetti il vissuto dei coniugi ricorda la povertà di certe relazioni amorose che si infrangono sulla scorza di cuori inariditi dalla vita metropolitana, la quale, piuttosto che avvicinarci l’un l’altro, ostacola la comunicazione e dunque la reciproca comprensione. È proprio l’incomunicabilità l’elemento chiave, simboleggiato dai lunghi monologhi della protagonista, utili a stabilire quell’intimo contatto verbale che sempre era mancato. Ecco il duplice paradosso: non solo il dialogo è demandato ad un esercizio solipsistico, ma sembra funzionare esclusivamente in assenza (psichica) del destinatario. L’impietoso epilogo giunge per ristabilire l’ordine, testimoniando l’essenza (ancora) strumentale della relazione.
Sensibile e ponderato, lo sguardo di Atiq Rahimi costruisce ogni inquadratura con l’intento di esaltare l’immagine della protagonista. La fiducia è ben ripagata dalla bravissima e affascinante attrice iraniana Golshifteh Farahani, in grado di caricarsi il film sulle spalle senza esitazioni. I primi piani prevalgono poiché l’attenzione è incentrata più sulla sofferenza interiore che fisica, non a caso le violenze si consumano fuori campo. La colonna sonora svolge il suo compito senza strafare, confermando il carattere equilibrato dell’opera, la cui cadenza rievoca il ritmo di una buona vecchia conversazione vis-à-vis, ricca di pause, interruzioni e silenzi che lungi dall’essere elementi di criticità dell’opera ne costituiscono, invece, il punto di forza.