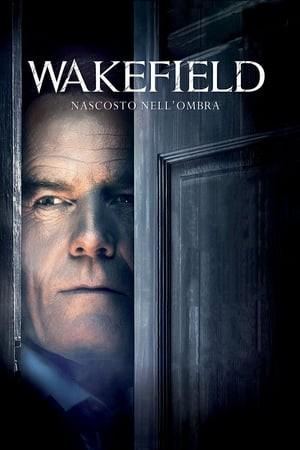Wakefield
Questa è la storia della catastrofe di Howard Wakefield.
Howard torna a casa.
La folla di un marciapiede, il silenzio delle voci, le luci della città.
Entra in stazione, sale sul treno, il paesaggio si frantuma nei riflessi sul vetro.
Il traffico, il lavoro, i documenti, il cellulare, le scadenze, la routine.
Il treno si ferma nel bel mezzo del nulla.
Anche Howard si ferma, nel bel nulla del mezzo del cammino della sua non vita.
Non ha risposto alle chiamate di Diana, sua moglie. Ora è sul vialetto, sta per entrare in casa, anche stasera è in ritardo, lei e le figlie sono già sedute a tavola per la cena. È stanco, sa che litigherà, non ne ha alcuna voglia. Poi accade qualcosa. Un procione attira la sua attenzione. Lui tenta di scacciarlo, ma l’animale fugge e si rintana nella soffitta sopra il suo garage, di fronte casa sua. Sale le scale, lo rincorre, poi lo trova e lo manda via. Ora è solo nella soffitta. E qui accade un’altra cosa. Si rende conto che dalla finestra ha una perfetta visuale della sua abitazione, che ha grandi vetrate. Osserva sua moglie, arrabbiatissima ormai, e decide, in quell’istante, di non rientrare a casa per la notte.
Inizia sempre con un attimo di buio. Ogni volta, passa inosservato, non ce ne accorgiamo mai. Comincia con una variazione impercettibile, come un alito di vento che sfiora le tempie. Quello è l’inizio del tornado che ti sconvolgerà l’esistenza. È impossibile accorgersi della sua nascita. Farà molto male. Fino alla fine. E sboccerai.
È la catastrofe.
Si sveglia di soprassalto. La soffitta è in disordine. Osserva sua moglie e le sue figlie. Valuta la possibilità di rientrare, ma lei di certo penserà che lui sia stato con un’altra donna. Non capirebbe la sequenza di scelte del tutto razionali che ha portato Howard a dormire nella piccola soffitta del suo garage. Allora aspetta. Rientrerà quando lei uscirà per andare a lavoro. Howard accenna un sorriso. I pensieri si rincorrono. Un procione gli passeggia nel cervello.
Entra in casa. Si lava, mangia qualcosa. È nella sua camera da letto, sul comodino c’è un taccuino, lo prende, sta per scrivere qualcosa, poi si ferma. In quel momento ha un’intuizione. Pulisce le tracce del suo passaggio, prende poche cose e torno nel suo nascondiglio. Si chiude nel suo mondo, in se stesso, non c’è posto per nessuno. Pensa a lei, a sua moglie. Ecco qual è stata la sua intuizione: «Diana ha sposato l’uomo sbagliato». Ora vede tutto in modo molto chiaro. Lei sta continuando la sua routine. Non è cambiato niente per lei. Vedi, Howard? La tua scomparsa non la sconvolge, anzi per lei è un sollievo che tu sia sparito. Ripensa al suo matrimonio, alla sua storia d’amore, a se stesso, alla sua famiglia. Rivede le immagini della sua esistenza che si affollano, in un turbinio di emozioni confuse, impenetrabili, insaziabili. Ripensa al rapporto con Diana, alla gelosia con cui condiscono i loro momenti di intimità, ai giochi di sguardi, alle provocazioni, al sesso, all’amore, all’odio, all’abitudine, ai giorni uguali, all’assenza. Si avvicina alla finestra. Sua moglie ha chiamato la polizia. Lui osserva le lacrime di quella donna che forse non ha mai amato veramente. Ed è di nuovo notte.
Dopo quell’attimo di buio, invisibile come una colomba nella neve, tutto resta uguale, ma il germe del divenire è già ovunque. Niente sarà più come dopo, perché quel dopo non ci sarà più. Si tratta di futuri abortiti, di deviazioni, di atomi di follia (e di follia di atomi). Si tratta di configurazioni inedite di tasselli primordiali, di nuovi meridiani (come direbbe Paul Celan). È la catastrofe che fa il suo corso, che fa la sua corsa, implacabile e poetica, come un procione affamato che scava tra i rifiuti.
Gli occhi di Howard cominciano a indossare un sguardo del tutto nuovo. A un certo punto, tra le sue infinite riflessioni, ci pone una domanda «chi non ha mai sentito l’impulso di sospendere la propria vita? Ve lo chiedo». Perché è esattamente questo ciò che lui ha fatto. Ha sospeso la sua vita, ha interrotto il fluire della sua esistenza. Pausa. Stop. Potrebbe essere la fine, lo sarà sicuramente. Non è un gioco: ha agito razionalmente, vorrebbe gridarlo in faccia a tutti coloro che ora stanno a casa sua, con la sua famiglia, i quali pensano che se ne sia andato, abbandonandoli. Ma lui è lì, è a pochi metri di distanza, passa più tempo con loro adesso di quanto abbia mai fatto prima. Si prende cura di loro, osserva le sue donne, le ri-conosce, le ri-scopre. Sua moglie, per esempio. Diana era la fidanzata del suo migliore amico, Dirk. Due amici, quasi fratelli, entrambi molto competitivi, e Howard trasforma anche questo in una sfida. Fa di tutto, e riesce a fare in modo, con la disonestà e la manipolazione, che il suo amico sbagli irrimediabilmente. Ora Diana è sua. L’ha conquistata, con l’inganno e la menzogna. A questo pensava quando rifletteva sul fatto che sua moglie avesse sposato l’uomo sbagliato («l’avrei mai voluta se non fosse stata la ragazza del mio migliore amico? È stata solo competizione?»). Lui non le ha dato scelta. La voleva, e non era propriamente amore. Ora lo ammette, lo riconosce. È stato un mostro. L’amore è un’altra cosa. L’amore è dare la possibilità di scegliere, di non essere scelti. Howard lo sa, eppure continua a manipolare sua moglie. La sua assenza è una presenza troppo ingombrante nella vita di Diana: sa che fino a quando lui resterà scomparso, lei non potrà ricominciare a frequentare un altro uomo, non senza lo stigma e gli occhi accusatori dei parenti, degli amici. La sua brama di controllo pulsa ancora molto forte. Si compiace di se stesso. «Sono ancora in possesso di mia moglie». Sparire in questo modo è stata una mossa di potere.
Ecco chi è Howard Wakefield.
Guarda sua moglie, da quella piccola finestra che filtra il mondo, l’intero universo, la sua stessa esistenza. Guarda sua moglie e pensa. La sua vita pesa di ogni minuto, ogni sbaglio, ogni negazione. Sono ormai tre giorni che è rinchiuso lì.
I meridiani si intrecciano. Nell’oscurità del significato si schiude il percorso della catastrofe. Non può che essere così. Del resto, è nel buio denso della selva che si compie ogni nascita. Sì, si intrecciano, si sovrappongono, ramificano, deviano, sviano, si estinguono, si caricano di mostri. Gli occhi di un procione scrutano nell’abisso della tua vita.
Era cominciata per caso, come la trovata di una notte. Ora invece è diventata una nuova vita, nascosto nell’ombra, e in lui si fa avanti con forza dirompente il desiderio di abbandonare tutto e tutti. No, non tornerà dalla sua famiglia. Sua moglie, le sue figlie, staranno tutti meglio senza di lui. Gli piace l’idea di lasciare da parte le responsabilità, i doveri, i ritmi del quotidiano, le incombenze della vita, le formalità, i “buongiorno” e i “buonasera”, i caffè, le domande anonime, le vacanze, le bollette, la suocera, i giorni uguali, il treno delle 18:56, l’ufficio, i documenti, le stagioni, il mestiere di esserci, i cappotti, i progetti, le sere disperate, i messaggi, la gita al mare, impietose pietà, putrefazioni quotidiane, la burocrazia dell’esistere. Tutto. Ogni cosa. Chi non sarebbe felice di abbandonare tutto ciò? Ma questa non è una fuga. Lo dice lui stesso: «fuggire è facile. Può farlo chiunque. Ma così si rimane sempre la stessa persona. Questo è diverso». Sì, questo è diverso. Qui non c’è niente che sia fine (a se stesso), non più. C’è la sospensione, il meccanismo alla base della dimensione poetica del significato. C’è la metafora, cioè la trasformazione, il mutamento, al punto più radicale e potente del suo essere. C’è la catastrofe. Allora lui si lascia andare, fluisce via dalla vita, si estrania, assume lo sguardo da fuori: diventa satellite, va sulla luna, osserva la sua vita mentre scorre, diviene spettatore della recita esistenziale di Howard Wakefield: lui è sul palco a recitare eppure è nel pubblico, allo stesso tempo, allo stesso tempio, quello nel quale si erge l’altare del Dio degli attimi che non possono che essere perduti.
Nessun uomo è un’isola. Così ha detto una volta John Donne. Sicuramente è così. Tuttavia Howard decide di diventarlo. Anzi, fa di più. Diventa un atollo, di quelli che l’oceano divora e non restituisce più. Rinuncia definitivamente agli oggetti materiali, alle comodità, si nutre solo di ciò che trova nell’immondizia, non cura neanche più la sua igiene, si lava di tanto in tanto nel bagno di servizio dei vicini. Non si rade, non si pettina, barba e capelli diventeranno lunghi, sporchi, aggrovigliati. Si priva di qualsiasi interazione diretta con le persone. Si lascia sommergere dall’oceano. L’atollo non c’è più. La camicia pulita, la rasatura perfetta, l’orologio, le carte di credito, la macchina, i clienti e tutto il resto dell’esercito di tenebre, ora è chiaro, non sono altro che vincoli che lo incatenavano a una vita che ormai non riconosce più come tale. C’è solo oceano, adesso. Sua moglie non dovrà preoccuparsi più. «Da lei non prenderò più niente. Né da quella casa. Mi manterrò come un naufrago, un sopravvissuto. Nascosto. Libero».
Nascosto.
Libero.
Howard non riemerge più, diventa il fantasma di se stesso. Un sopravvissuto alla vita. Un naufrago. “Castaway on the room”. Va alla deriva nella sua stanza, che è il cosmo intero. Un fantasma che trascina catene, si aggira nel castello gotico che ha nel cuore, disabitato, spaventoso, tetro.
«Diventerò l’Howard Wakefield che sarei dovuto essere».
Passano i giorni, le settimane. Lui è sempre lì, in quella crisalide senza tempo, ma con tutti i temporali. Qualcosa di tremendo e meraviglioso sta accadendo dentro di lui. È la catastrofe. Continua a pensare, a riflettere, a immaginare. Diana, le sue figlie, il senso di ogni cosa. L’autunno arriva senza avvertire. Inizia a vedersi davvero, come non aveva mai fatto. Per la prima volta nella sua vita, toglie ogni maschera. Guarda il suo riflesso e si riconosce. Inizia a realizzare che l’egoismo e la gelosia hanno guidato la sua vita, influenzandone i comportamenti. È lui il solo responsabile, è lui il colpevole. I suoi sbagli, le sue sconfitte, i suoi fallimenti, le sue frustrazioni: è colpa sua. Sei tu il tuo assassino, Howard. Come ognuno di noi lo è di se stesso.
Arriva l’inverno. Il gelo penetra ovunque. Inaspettata, l’umanità irrompe nelle sue giornate. Due ragazzini, pazienti del suo vicino di casa, scoprono il suo nascondiglio. Lui si rende conto che non è più al sicuro, potrebbe essere scoperto. Inizia a uscire di notte, scava tra i rifiuti, cammina in riva al lago, affonda lo sguardo nel cielo, si perde, si ritrova dopo così tanto tempo. Immagina mille varianti di un possibile incontro fortuito con sua moglie. Il mondo si sta aprendo, lui lo contiene, ne percepisce l’immensità. La notte è piena di stelle. Sa cos’è successo.
«Non ho abbandonato la mia famiglia. Ho abbandonato me stesso».
Devastante. Abbandonare se stessi, e come si fa? Come si va sulla luna, come si diventa satellite? La sospensione, lo spaesamento, lo sguardo da fuori. È un variazione esistenziale radicale, estrema, una rivoluzione ontologica che ridefinisce i contorni della mente.
Ora non sa se è meglio andare via dalla soffitta, annullarsi completamente, dormire nei boschi, lasciarsi sparire ancora di più. Il fantasma si accorge che la vita continua. Forse sono davvero più felici senza di lui. Le figlie non devono più sentirsi in dovere di volergli bene. Diana non si sente più soffocare. Ma un dubbio gli sconvolge la mente.
«Fino a che punto lascerò che vada avanti tutto ciò?».
Cosa farai, Howard?
Tornerai a casa o resterai un naufrago, un fantasma, immerso nell’oscurità ai margini del mondo?
Ha paura.
Il gelo dell’inverno lo ucciderà. Deve prendere una decisione. Tornare, sparire per sempre, lasciarsi morire. Guarda negli occhi il procione che quella sera di tanti mesi prima lo aveva condotto in soffitta. È sempre lo stesso, non ho dubbi. Si gela, lui è malnutrito, debilitato, sporco, e non è mai stato tanto consapevole di se stesso, malgrado i dubbi, le incertezze e i dilemmi strazianti. Lui è Alice e ha attraversato lo specchio. Ripercorre la sua vita e vede chiaramente tutti gli errori che ha commesso, ed è così chiaro che la colpa è sua, non degli altri, come si è sempre raccontato. E poi, un giorno, semplicemente, succede.
Diana comincia a frequentare un altro uomo. Per uno strano scherzo del destino, costui si scopre essere Dirk. Howard è immerso nel vento gelido dell’inverno più potente della sua vita. Esce di notte, cammina nel bosco. Ci sono pezzi di buio incastrati nei suoi occhi. Inspira avidamente. Piange. Respira l’universo. Ogni momento, ciascun evento, qualsiasi dettaglio, tutto, ogni recondito aspetto della sua vita confluisce in questo preciso istante. È l’ora della catastrofe.
La catastrofe di cui parlo è da intendersi nella sua accezione matematica. Ovvero morfogenesi, cambiamento di forma, ridefinizione identitaria, genesi, rinascita. La catastrofe è il punto di svolta, di non ritorno, di mai più. È il mutamento esistenziale. È il risultato di una serie di cambiamenti quantitativi che, accumulatisi nel tempo, a un certo punto, determinano un mutamento qualitativo. Come l’acqua che, attraverso variazioni quantitative (la temperatura che si abbassa progressivamente), a una certa soglia (a zero gradi), cambia forma e diventa ghiaccio. La catastrofe. Si verifica a tutti i livelli. In natura, nelle relazioni sociali, nella dimensione artistica, in qualunque espressione umana, nella dimensione macro e in quella micro e in quella individuale. Howard trova il suo momento critico, il punto catastrofico, proprio lì, in mezzo al bosco, nel gelo della notte. Tante, piccole, progressive variazioni quantitative lo hanno condotto a ciò, e qui avviene il mutamento di forma. Howard Wakefield fiorisce.
C’è una poesia di Czeslaw Milosz che mi è venuta in mente più volte, guardando questo film. Si intitola La finestra.
Ho guardato dalla finestra e ho visto
un giovane melo diafano nel chiarore.
E quando ho guardato un’altra volta all’alba
là c’era un grande melo carico di frutti.
Devono quindi essere passati molti anni
ma non ricordo cosa sia successo nel sonno.
E mi viene in mente Borges, e le sue Finzioni, e il fatto che «nel sogno dell’uomo che lo sognava, il sognato si svegliò». E la domanda perenne di quel genio nato direttamente dal mal di testa di Dio, Davi Lynch: «siamo come il sognatore che sogna e vive nel sogno. Ma chi è il sognatore?».
Siamo davanti alla finestra, osserviamo l’albero dell’esistenza, i suoi rami incomprensibili, meravigliosi, tremendi, perfetti, sanguinanti. Nel sonno, si compie la nostra singola (molteplice) vita. Siamo il sognatore e siamo il sognato e siamo il sogno. La finestra è l’ingresso nel bosco, non dobbiamo fare altro che perderci, ma per dirci e per darci. E in qualche modo nascere.
Howard si sveglia nel sogno che stava sognando. È il sognatore, è il sognato. E non si capacita del tempo trascorso, del tempo perso e quello terso riflesso negli occhi della persona che ama. Diana, le bambine. I rifiuti, la polvere, il procione che forse è un angelo. L’abbraccio della mia famiglia che è certamente il paradiso.
E invece io l’ho ignorato, ho continuato a dormire, non mi sono svegliato nel sogno e ho perso tutto, ho perso me stesso. Ho paura di essere come Howard. Soprattutto, temo di essere lontano dalla catastrofe. Ma non potrei saperlo in nessun caso. Sono sveglio nel mio sogno? Quanto tempo è passato? Quanto tempo è futuro? Voglio andare in riva al lago, immergermi nel bosco, diventarmi, essere io. Tornare dalla mia Diana, portarla con me sulla Luna e baciarla al chiaro di Terra.
Sì.
Guardo dalla finestra. Immagino un altro me stesso, anche lui alla finestra, nella sua personalissima soffitta, incapace di dormire, e poi ne immagino un altro, che magari dorme e sogna di essere sveglio, di essere me, di essere un procione che rovista tra i rifiuti.
«Se tornassi, come inizierei? Come può un uomo nella mia situazione spiegare se stesso alla moglie? Penserà che ho perso il senno. Semmai, l’ho recuperato. Completamente. Riesco a vederlo perfettamente. Sono io ad aver fabbricato tutta la cosa. La gelosia, il risentimento, i bisogni dettati dall’egoismo. Howard è la vittima, Howard è l’aguzzino, Howard ha fatto suo il mondo. Quella era la mia prigione. Lì e da dove sono fuggito. Cosa sono adesso? Un emarginato del cosmo. Amo mia moglie come non l’ho mai amata prima»
Howard è in fiore.
Nella scena più significativa del film, con un montaggio secondo me ottimo, nell’apice della curva catastrofica, Howard Wakefield sboccia. Viene alla luce. È stremato, come ogni neonato. C’è sangue dappertutto. E ci sono lacrime, sorrisi, estasi, dolore, immensità.
Adesso sì, Howard. Ora sei davvero tu. Qualcosa è sorto.
«Amo mia moglie come non l’ho mai amata prima».
E sa che se tornasse dall’esilio ci sarebbe l’ampia possibilità di perderla.
Lo legge chiaramente nei suoi occhi. Si è infatuata.
Ma è giusto che lei cerchi un po’ di tenerezza, perché non dovrebbe? Suo marito è scomparso da mesi, probabilmente morto. Ha bisogno di colmare l’angoscia, di calmare il demone dell’assenza.
Howard la osserva, ha le lacrime agli occhi, è l’amore della sua vita, la vita del suo amore, è tutto così incredibilmente chiaro! E lui e lei e le bambine, che bambine non sono più, e l’inverno, la notte, la paura di essere veri, le strategie di eclissi, i giorni fatti di minuti fatti di secoli, la finestra, l’universo, le comete, le coperte, i baci all’alba, le sue dita sulla schiena e “indovina cosa scrivo”, i tramonti all’improvviso, le passeggiate mano nella mano, mani nel domani, il primo bacio, il secondo, l’ennesimo, ancora, ancora, sospiri, neve, cigno, musica, insetti, carezze, strofe, e speranze e desideri e nuove albe, indizi di futuro, disegni, fuoco, dinosauri, ogni cosa, ogni casa, se stiamo insieme.
«Se e lui quello che vuoi, amore mio, è giusto che tu possa scegliere stavolta».
Basta menzogne, manipolazioni, egoismi.
È Natale, lui manca da un sacco di mesi (mi piace pensare che siano nove: il tempo di una gravidanza, di una ri-nascita). Ora è pronto, si sente libero, finalmente libero. Utilizza gli ultimi soldi che gli erano rimasti per ripulirsi e rendersi presentabile, comprare un completo nuovo e riprendere la sua vita dal punto in cui la aveva interrotta.
È sul vialetto di casa.
Come quella sera.
Vede le sue donne intorno all’albero di natale.
Immagina i possibili scenari, le due possibili reazioni da parte di Diana e le ragazze.
La prima è di pura gioia.
La seconda è di indicibile terrore.
Malgrado il dilemma, Howard avanza.
Accetta ogni conseguenza.
È un uomo libero.
Ama la sua vita, sua moglie, la sua famiglia.
Infila le chiavi nella serratura.
Apre la porta, varca la soglia, sorride.
"Sono a casa", dice.
https://ilbuioinsala.blogspot.com/2020/05/passeggiate-il-cinema-della-poesia-5.html