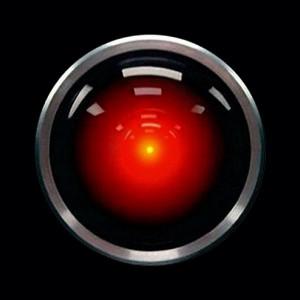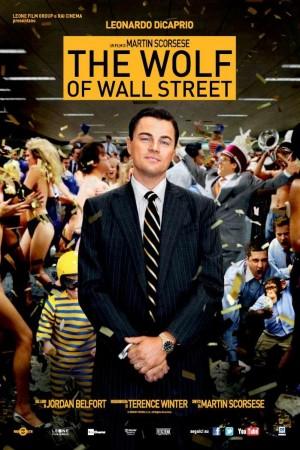Scorsese propone la storia vera di uno squalo della finanza e del suo fastoso impero devoto all’illegalità, romanzandola con un’esplosione di edonismo che conquista il centro della scena ma al contempo separa l’utile e il dilettevole.
Jordan Belfort è un giovane ammaliato da Wall Street e dalle buste paga dei broker che vi lavorano, gente depravata, senza ritegno, la cui massima aspirazione è sballarsi e arricchirsi. Archetipo del self-made man, insegue il sogno americano in sella ad un caterpillar demolendo la propria integrità, sia morale che fisica, gli affetti familiari, i rapporti amicali e, soprattutto, i risparmi di una vita che molti americani avevano messo da parte con sacrificio. Ma proprio quando il sogno è all’apice della sua materializzazione sopraggiunge il brusco risveglio, perché, come ci ricorda l’irascibile padre di Jordan, prima o poi tutti i nodi vengono al pettine.
Sin dalla scuola primaria i maestri insegnano agli alunni che il dono della sintesi è un requisito fondamentale. Eppure, oggi, a giudicare dalla massiccia produzione di film inutilmente prolissi, il cinema americano sembra voler rovesciare questo pericolosissimo luogo comune e The Wolf of Wall Street si candida all’oscar come fulgido esempio di tale tendenza. In principio il confronto fra Jordan e il suo mentore Mark fuorvia lo spettatore che, convinto di assistere alla critica spietata dei meccanismi dell’alta finanza condita da qualche nota di colore, viene improvvisamente travolto da un’orda di carne in perpetua convulsione sotto un diluvio di cocaina e Quaalude. Magari il regista vuole focalizzare l’attenzione sui cortocircuiti psicologico-sociali generati dal successo economico, tanto che ad un tratto Jordan guarda dritto in macchina cercando di convincere lo spettatore che non è poi così importante spiegare il funzionamento dei suoi intrallazzi finanziari. Peccato che non vi siano i presupposti per entrare in empatia con i personaggi, sbiadite macchiette incapaci di emergere dal turbinio degli eventi e far riflettere sulle contraddizioni delle loro vite. Sarà forse semplicemente un film sulla dipendenza dalle droghe? No, nemmeno. Più si va avanti e più la rappresentazione scorre confusa, approssimativa, farcita di scene accessorie atte a soddisfare i bisogni ventrali degli spettatori. Completano il quadro gag inverosimili e sconclusionate (il bacio con la vecchia zia), citazioni forzate (lo yacht affonda in stile Titanic mentre Di Caprio abbraccia la sua “Rose”) e, dulcis in fundo, la scena agghiacciante che in pochi secondi concentra l’intero patrimonio mondiale di stereotipi sugli italiani: un equipaggio che mangia e canta mentre balla tarantolato. Il risultato finale? Un film senza identità che vuole strafare e che se da un lato, forse, non annoia, dall’altro non risulta più avvincente di un minestrone ben ripassato.
Martin Scorsese strizza l’occhio a Baz Luhrmann (Il grande Gatsby, 2013) e fa volteggiare la cinepresa tra folle orgiastiche in preda alla perdizione. Ogni strumento vale per fare spettacolo, dal ralenti al flashback. Resta tuttavia la sensazione dell’effetto ludico fine a sé stesso. Certo, Di Caprio rimane ancora al top della forma ed è così convincente da essere quasi pericoloso nel momento in cui rende magnetico e seducente un individuo deprecabile. Ma queste non sono scelte dell’attore e se proprio dovessi consigliare la visione a qualcuno mi rivolgerei ai fan sfegatati del buon Leo. Gli altri sono invitati a scegliere uno dei tanti temi trattati superficialmente in questa pellicola e ad approfondirlo con opere più mirate ed efficaci: Wall Street (Oliver Stone, 1987) per quanto riguarda la finanza e la vita da broker, Shame (Steve McQueen, 2011) se vi interessano i risvolti psicologici dell’overdose da sesso nell’età contemporanea e Requiem for a dream (Darren Aronofsky, 2000) per affrontare la piaga della dipendenza nelle sue implicazioni più oscure.
Jordan Belfort è un giovane ammaliato da Wall Street e dalle buste paga dei broker che vi lavorano, gente depravata, senza ritegno, la cui massima aspirazione è sballarsi e arricchirsi. Archetipo del self-made man, insegue il sogno americano in sella ad un caterpillar demolendo la propria integrità, sia morale che fisica, gli affetti familiari, i rapporti amicali e, soprattutto, i risparmi di una vita che molti americani avevano messo da parte con sacrificio. Ma proprio quando il sogno è all’apice della sua materializzazione sopraggiunge il brusco risveglio, perché, come ci ricorda l’irascibile padre di Jordan, prima o poi tutti i nodi vengono al pettine.
Sin dalla scuola primaria i maestri insegnano agli alunni che il dono della sintesi è un requisito fondamentale. Eppure, oggi, a giudicare dalla massiccia produzione di film inutilmente prolissi, il cinema americano sembra voler rovesciare questo pericolosissimo luogo comune e The Wolf of Wall Street si candida all’oscar come fulgido esempio di tale tendenza. In principio il confronto fra Jordan e il suo mentore Mark fuorvia lo spettatore che, convinto di assistere alla critica spietata dei meccanismi dell’alta finanza condita da qualche nota di colore, viene improvvisamente travolto da un’orda di carne in perpetua convulsione sotto un diluvio di cocaina e Quaalude. Magari il regista vuole focalizzare l’attenzione sui cortocircuiti psicologico-sociali generati dal successo economico, tanto che ad un tratto Jordan guarda dritto in macchina cercando di convincere lo spettatore che non è poi così importante spiegare il funzionamento dei suoi intrallazzi finanziari. Peccato che non vi siano i presupposti per entrare in empatia con i personaggi, sbiadite macchiette incapaci di emergere dal turbinio degli eventi e far riflettere sulle contraddizioni delle loro vite. Sarà forse semplicemente un film sulla dipendenza dalle droghe? No, nemmeno. Più si va avanti e più la rappresentazione scorre confusa, approssimativa, farcita di scene accessorie atte a soddisfare i bisogni ventrali degli spettatori. Completano il quadro gag inverosimili e sconclusionate (il bacio con la vecchia zia), citazioni forzate (lo yacht affonda in stile Titanic mentre Di Caprio abbraccia la sua “Rose”) e, dulcis in fundo, la scena agghiacciante che in pochi secondi concentra l’intero patrimonio mondiale di stereotipi sugli italiani: un equipaggio che mangia e canta mentre balla tarantolato. Il risultato finale? Un film senza identità che vuole strafare e che se da un lato, forse, non annoia, dall’altro non risulta più avvincente di un minestrone ben ripassato.
Martin Scorsese strizza l’occhio a Baz Luhrmann (Il grande Gatsby, 2013) e fa volteggiare la cinepresa tra folle orgiastiche in preda alla perdizione. Ogni strumento vale per fare spettacolo, dal ralenti al flashback. Resta tuttavia la sensazione dell’effetto ludico fine a sé stesso. Certo, Di Caprio rimane ancora al top della forma ed è così convincente da essere quasi pericoloso nel momento in cui rende magnetico e seducente un individuo deprecabile. Ma queste non sono scelte dell’attore e se proprio dovessi consigliare la visione a qualcuno mi rivolgerei ai fan sfegatati del buon Leo. Gli altri sono invitati a scegliere uno dei tanti temi trattati superficialmente in questa pellicola e ad approfondirlo con opere più mirate ed efficaci: Wall Street (Oliver Stone, 1987) per quanto riguarda la finanza e la vita da broker, Shame (Steve McQueen, 2011) se vi interessano i risvolti psicologici dell’overdose da sesso nell’età contemporanea e Requiem for a dream (Darren Aronofsky, 2000) per affrontare la piaga della dipendenza nelle sue implicazioni più oscure.