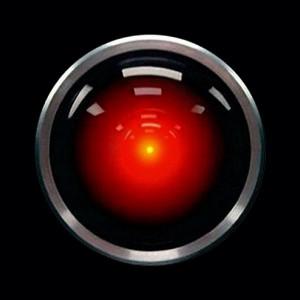Inedito in Italia, Dogtooth racconta una storia di reclusione, dove la paura per il mondo che ci circonda induce a cercare rifugio in prigioni poco dorate e tuttavia rassicuranti. Ma qual è il prezzo da pagare? E, soprattutto, fino a che punto può funzionare la negazione della realtà?
Una famiglia, padre madre e tre figli, vive in totale isolamento dentro la propria villa. In questo microcosmo artificioso l’esperienza di vita è totalmente slegata dal mondo esterno, ad eccezione del padre, il solo a poter uscire di casa, ma, soprattutto, padrone indiscusso delle sorti dei suoi cari. Sostenuto dalla moglie, alleva la prole plasmando un universo distorto, dove gli aerei piovono dal cielo e le donne partoriscono animali. La manipolazione è totale e include anche il linguaggio, ai figli viene insegnato che la carabina è un uccello e il mare una sedia. Per quanto bislacca, l’educazione impartita è tutt’altro che una simpatica burla e l’acquiescenza dei tre giovani concorre nel rafforzare il carattere surreale degli eventi, con il risultato di generare nello spettatore una persistente sensazione di smarrimento. Nonostante tutto, la messinscena sembra funzionare alla perfezione, ma una forza legata al mondo esterno corromperà l’insano equilibrio familiare…
Dogtooth ci insegna innanzitutto che da un’idea semplice si può ricavare un’opera dai molteplici significati e dunque capace di alimentare la curiosità del pubblico. La presenza dell’istanza narrante quasi si dissolve nel fluire degli avvenimenti, la loro genesi è sconosciuta e ciò che ne rimane è l’essenza. Da qui scaturisce il walzer dei significati, la cui ricerca è demandata allo spettatore. Fra le varie allegorie, si distingue più nettamente la critica alla società occidentale contemporanea, che se da un lato viene negata, dalla’altro è fedelmente riprodotta in scala. I grandi poteri transnazionali (il padre) hanno il totale controllo del sistema e con la connivenza delle élite locali (la madre) mantengono il controllo sulla popolazione (i figli) distratta da futili impegni nonché narcotizzata dai media, cui spetta il compito di tenere in vita un apparato comunicativo fittizio ed estraniante. Affinché tutto sia stabile, la fedeltà e l’appartenenza devono essere incondizionate e vengono garantite paventando minacce esogene che rinsaldano la coesione intra-gruppo. Che sia un gatto o il terrorismo a spaventare non conta poi molto, l’importante è la presenza del nemico che ci rende tutti cani da guardia, pronti ad abbaiare per proteggere il padrone e il nostro giardino totalizzante. Purtroppo lo status quo e gli sforzi profusi nel mantenerlo divengono tristemente ridicoli laddove se ne evidenzia il nonsenso di fondo. La società è una costruzione arbitraria e in quanto tale priva di fondamento. Lo stesso linguaggio non è altro che l’invenzione di termini per definire oggetti, ma poi, infine, non c’è modo di spiegare qual è il nesso tra una parola e la sua controparte reale. Perché chiamiamo “cane” un mammifero a quattro zampe che abbaia? Non vi è risposta. Analogamente, non c’è spiegazione per le scelte di questa famiglia. Di certo, l’abisso della mancanza di significato ci terrorizza e ciò alimenta il meccanismo per cui è molto più rassicurante credere a una falsa verità cha a una vera relatività.
Forse non è un caso che questa pellicola pregna di pessimismo nasca in Grecia, all’alba della crisi che l’ha martoriata. Mai come in questo caso il cinema si fa precursore della storia. Giorgos Lanthimos immortala lo zeitgeist di un popolo chiamato ad affrontare la minaccia incombente, evidenziando però l’immobilità e l’apatia come reazioni principali. L’individuo si chiude nel suo mondo diventando vulnerabile come un agnello sacrificale, il cui candore indifeso si manifesta nella fotografia lattescente. Al contempo, l’omogenea lentezza del ritmo regala una sensazione di inesorabilità degli eventi cui è difficile sfuggire. A ciò si aggiungono le prove convincenti dell’esiguo cast, in particolare gli interpreti dei figli lasciano trasparire con calcolata inespressività un analfabetismo delle emozioni a tratti inquietante. Il tutto è sorretto dalla regia morigerata di Lanthimos, che mira con successo all’introspezione e ricorda per analogia il cinema di altri registi più noti, fra tutti Haneke e i fratelli Dardenne. L’assenza di elementi comici o spettacolari, unita alla scarsa fama internazionale del regista ha interdetto Dogtooth dal Belpaese per più di dieci anni. Solo grazie al successo ottenuto dal regista con le opere successive la pellicola è stata finalmente distribuita, peraltro ad agosto 2020, in piena pandemia. Non si tratta così un (quasi) capolavoro.