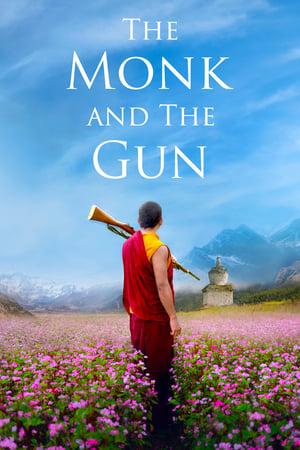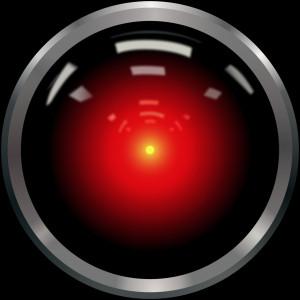Una commedia degli equivoci vecchio stile ma anche una favola con morale ad uso e consumo del pubblico occidentale
Regno del Bhuthan, 2006; dopo l’abdicazione dell’amato sovrano il piccolo stato, per la prima volta nelle sua storia, avrà delle libere elezioni.
Già ma cosa sono, a che servono e soprattutto come si vota?
Se lo chiedono un po’ tutti gli abitanti del paese, soprattutto quelli del piccolo villaggio rurale scelto da Pawo Choying Dorij come sfondo del suo secondo lungometraggio.
Qui si intrecciano diverse vicende.
C’è l’inviata del governo che dovrà organizzare le elezioni fittizie che si svolgeranno nel villaggio e che serviranno sia come test nazionale per vedere come andranno le cose, sia per spiegare a tutti la novità.
Ad affiancarla una giovane donna locale la cui quiete familiare verrà proprio minacciata dalla competizione.
Il marito infatti è un convinto sostenitore del candidato per il progresso, malvisto tanto dagli altri abitanti, quanto dalla madre della moglie e dagli altri parenti che se la prenderanno anche con sua figlia, accusandola di essere la figlia di un traditore.
C’è poi un collezionista di armi americano accompagnato da una “guida” locale alla ricerca del fucile del titolo internazionale (The monk and the gun).
Infine c’è un monaco incaricato dal proprio Lama di trovare due fucili per una cerimonia che, secondo il maestro, “rimetterà le cose a posto”.
La prima cosa che balza agli occhi è che C’era una volta in Bhutan è una perfetta commedia degli equivoci vecchio stile con dei tempi perfetti.
Esemplare, ad esempio, la sequenza in cui l’americano con la sua guida, ritornano dall’anziano possessore dell’ambito fucile per concludere la compravendita proprio mentre il giovane monaco se ne va dopo essersi assicurato il prezioso oggetto.
Lo stesso intento del lama, quello di usare i fucili per rimettere le cose a posto, porta lo spettatore ad immaginare un’evoluzione degli eventi che verrà poi smentita dal finale.
Anche il protagonista principale è un perfetto personaggio comico con quella sua aria fintamente ingenua che ricorda il Peter Sellers di Hollywood Party.
C’era una volta in Bhutan, da questo punto di vista, svela uno sguardo che, evidentemente, ha macinato i grandi classici hollywoodiani del genere assorbendone tempi e regole pur piegandoli ad un racconto fortemente caratterizzato da ritmi diversi dal cinema occidentale.
Il mondo raccontato da Pawo Choying Dorij è al tempo stesso lontano dal nostro eppure così simile.
Prendiamo il personaggio del marito della donna incaricata di aiutare la funzionaria governativa.
Le sue piccole invidie e gelosie nei confronti dei vicini sono le stesse che conosciamo noi.
Tuttavia, terminata la visione con un sorriso leggero, sorgono immediatamente dei dubbi.
Purtroppo non ci si riesce a liberare dalla sensazione che C’era una volta in Bhutan sia un film costruito apposta per compiacere il pubblico occidentale.
C’è quel tocco di esotico che non guasta mai, visto con un occhio alle volte sin troppo carico di facile ironia.
Esempio lampante è la scena del monaco che in un bar chiede dell’acqua nera ovvero della Coca Cola) ed anche la contrapposizione tra l’Occidente, rappresentato dall’americano, dalla democrazia e dalla modernità e l’Oriente tranquillo, placido e sereno del Bhutan è un po’ troppo manicheo.
Ma forse quello che “insospettisce”di più è la dimensione da fiaba morale (buddista) dell’intero film.
Nel finale infatti tutti i protagonisti troveranno la propria strada.
La donna ritroverà l’unione familiare, l’americano imparerà a liberarsi dall’attaccamento, la funzionaria governativa tornerà nella metropoli arricchita dalla semplicità della gente locale ed il monaco riprenderà la sua esistenza tranquilla.
E tutti vissero felici e contenti, verrebbe da dire, ma questo tono moralista di chi voglia impartire una lezioncina sui valori semplici della vita ad uso e consumo dell’uomo occidentale schiavo dei vizi e di una vita frenetica, onestamente ce lo saremmo anche risparmiato, sebbene siamo sicuri che il regista sia in buona, anzi ottima fede.
EMILIANO BAGLIO